Siccome siamo in tempo di vendemmia e questa sera mi è saltato un impegno, fresco di un piccolo esperimento di cui parlerò più avanti ho pensato di rimettere mano al blog e scrivere due righe sul mondo del Lambrusco, un vino che ho imparato ad apprezzare davvero solo in tarda età, e che ha caratteristiche uniche sotto vari aspetti, cogliendo l’occasione per mettere temporaneamente in pausa la ormai ossessiva ricerca sugli antichi vitigni della mia regione che al momento ha passato le 300 voci (!).
Quindi: Lambruschi. Quante cose si possono dire su una famiglia di diversi vitigni che solo un secolo fa era considerata al livello dei migliori champagne? Un vino che invece oggi è ormai sinonimo di bevanda economica dolciastra e a basso costo, venduta in bottiglioni formato famiglia in tutto il mondo? Ci sarebbe da discuterne e scrivere per settimane. Ma rimaniamo nel seminato e parliamo solo di come si produce e come si produceva questo vino, senza dilungarci sulle singole varietà, sulla coltivazione, e sulla storia più recente.
Amabile o secco?
Se oggi la risposta ti pare ovvia a meno che tu non sia un russo o un sudamericano, così non era nell’Italia postunitaria di fine Ottocento. Se i Lambruschi a Reggio Emilia avevano un residuo zuccherino che andava dallo 0 al 30 (da Secco ad Amabile), a Modena arrivava tranquillamente a 72, praticamente come un Moscato dell’epoca! Teniamolo sempre in mente questo, perchè non si possono disaminare documenti storici senza considerare i gusti dell’epoca1.
Il Lambrusco attorno al 1860
Scrivo “attorno” a questa data perché questi erano gli anni in cui il nostro più eminente rappresentante dei Lambruschi modenesi il cavalier Francesco Aggazzotti pubblicava articoli e libretti sul mondo del vino. Può essere interessante sapere che Francesco aveva concluso che per fare un buon vino in collina, ad esempio il Lambrusco dalle graspe rosse (ma in realtà parlava anche di quelle uve scure conoscite come corve, o crove, come la crovetta, covrone, ecc. e la dimenticata amaraguscia di cui parlerò a brevissimo) era necessario ridurre il tempi della prima fermentazione in tino a “soli” 4-5 giorni, ma soprattutto era fondamentale aggiungervi uve bianche tenere (gradesana, pellegrina) e sempre correggere con trebbiano modenese2, alla faccia delle DOC folli dei nostri giorni. Ah, la misteriosa arte spesso clandestina degli uvaggi!3
Oltre a quanto detto sopra, non è mistero che Francesco intendesse come IL Lambrusco il suo figlio prediletto ovvero il Lambrusco di Sorbara, che d’altronde era riconosciuto come il migliore, se non unico vino “fine da pasto” (Ramazzini li classificava così: “di lusso”, “da taglio”, “da pasto”, e quest’ultima categoria a sua volta divisa in fini, comuni ed inferiori4). Se oggi il suo cugino di collina precedentemente menzionato, il celeberrimo Lambrusco dalla Graspa Rossa e le sottovalutatissime (a mio avviso) uve Salamine, un tempo considerate semplici uve da taglio, oggi godono di altrettanta fama (d’altronde ci siamo dimenticati quasi completamente ad esempio del Lambruscone di Fiorano), a quei tempi questi erano tutti considerati Lambruschi “di ripiego”, da coltivarsi fuori da quella zona benedetta dai Signore che è, stando al cavalier fioranese, il Sorbara. Il Lambrusco, diceva Aggazzotti, in collina non viene poi così sublime (sic.), salvo in terreni sabbiosi ed alluvionali come quelli a ridosso dei fiumi e comunque con abbondanti accorgimenti. E questo perché, per lui, era fondamentale che le radici delle viti potessero “sentire il suono delle campane”, ovvero essere leggeri e permettere all’acqua di scivolare rapidamente attraverso la sabbia e perdersi nel suolo.
E’ da notare che questa opinione non era sempre stata condivisa, al punto che in epoca rinascimentale le colline attorno a Vignola e Castelvetro, erano considerate terre di grandi vini al punto che la corte estense ne chiese “piante con radici”, e nel 1541 un noto documento attesta che il vino della corte ducale venisse proprio da Guiglia5. E’ stato solo dopo il Rinascimento che Bologna dimenticò la sua vocazione vinicola per dedicarsi anima e corpo alle uve da tavola. Perchè esattamente, io ancora sto cercando di capirlo.
Va anche premesso che man mano che mi addentro nei contorti meandri della documentazione storica sul mondo del vino, mi sento di dire, la consapevolezza che questo prodotto dovessere essere necessariamente molto diverso da quel che conosciamo oggi aumenta, come sicuramente cambiano i parametri con i quali veniva riconosciuto un vino di qualità. Se solo cento anni fa abbiamo visto quanto dolce fosse il vino dalle mie parti, immaginiamo cosa potesse essere mille anni fa, continuamente corretto da spezie e miele, o come facevano gli antichi acqua di mare o resine. Vien quindi da chiedersi se la valutazione di Aggazzotti potesse valere anche oggi senza calarsi prima nei panni di un uomo dell’Ottocento. Senza considerare le opportunità che oggi l’enologia e le tecniche agraria ci metterebbero a disposizione per rivalutare vitigni ormai perduti. L’unico grosso scoglio, a mio avviso, è la completa industrializzazione di tutti i processi agricoli che ci danno vini di cantina corretti da un numero infinito di accorgimenti più o meno accettabili.
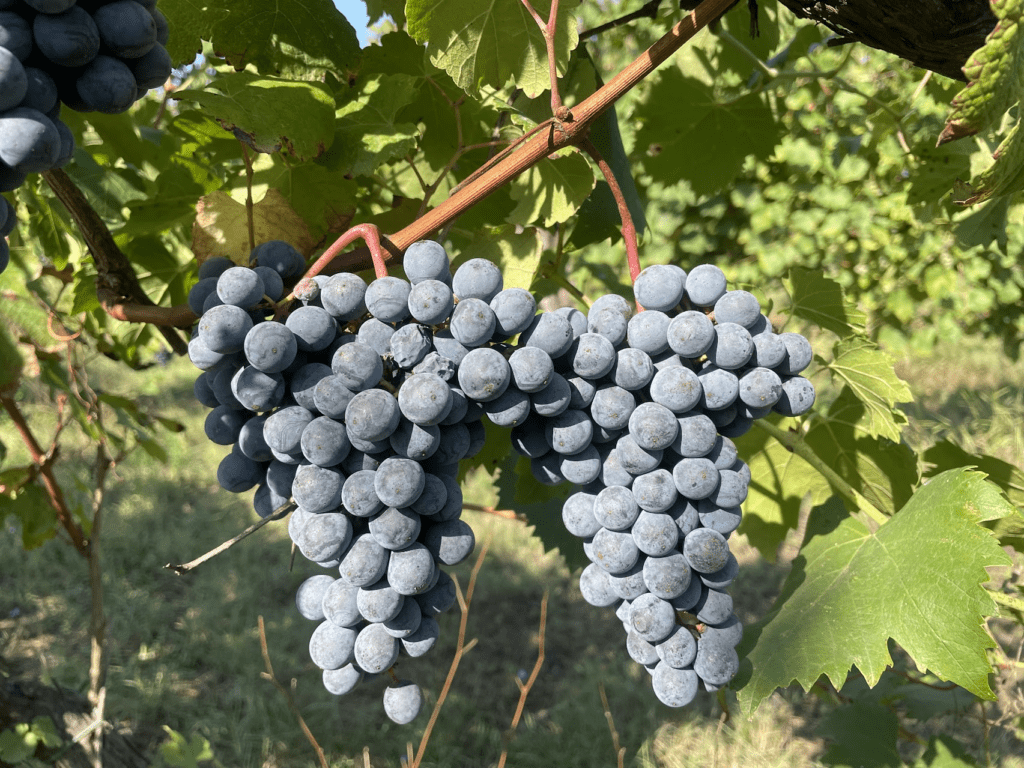
Le quattro vite della vite
Vale la pena fare un’ultima premessa quando si parla del vino di una volta, perché il vino vero e proprio non era l’unica bevanda che nasceva da queste uve.
Se dopo il Rinascimento, durante il quale la qualità del vino ricalcava la gerarchia nobiliare e il volgo beveva vin bollito, nelle nostre campagne fino solo a pochi decenni fa il vino vero e proprio, spesso e volentieri, veniva venduto o consegnato ai padroni dai mezzadri. La storia delle nostre uve nelle fattorie sicuramente non finiva dopo la prima spremitura. Innanzitutto, le vinacce del cappello che si era sollevato dal tino venivano passate al torchio, e il risultato di questa spremitura messo assieme alla prima (vedi, più avanti l’opinione di Aggazzotti su questo tema).
Esisteva una seconda fase, in cui veniva prodotto il cosiddetto mezzo vino, o vino da famiglia. È mia personale convinzione che alcune uve considerate di basso grado e poco valore, come quelle bianche della bassa modenese, venissero usate così com’erano per fare mezzo vino, poiché venivano comunque impiegate per il taglio, senza necessariamente essere utilizzate solo nella loro seconda vita nel torchio. La pratica comune era quella di passare l’acqua sulle vinacce torchiate per estrarre i succhi residui. Il vino che ne risultava era fresco e piacevole, soprattutto nelle campagne assolate. Francè consigliava di rinforzarlo con il “coltellino svizzero” di tutti i vitigni, il mai abbastanza elogiato Trebbiano, che noi a Modena ormai abbiamo relegato quasi completamente alla produzione di Aceto Balsamico Tradizionale. Nei Trebbiani coltivati in collina o in montagna, che secondo lui erano i migliori, “si può passare i due terzi d’acqua e resta il vino anche gagliardo per bersi dalla famiglia”6. Parlando di vitigni, certe uve erano viepiù preferibili da famiglia, per essere piuttosto precoci e permettere ai contadini di avere vino per la campagna già in tarda estate, varietà come la covra, la negretta, o la rossetta7.
La terza fase era quella del terzanello (o localmente, tarzanello), in cui le vinacce ormai esauste venivano nuovamente annaffiate con acqua, ma questa volta lasciate riposare per qualche tempo in attesa di una nuova fermentazione, che potesse estrarne tutto il possibile. Qui, oltre al Trebbiano che Francè ancora una volta ci consiglia di aggiungere, a volte si rinforzava il tutto con un po’ di miele, perché, sai com’è, di dolce non ne era rimasto granché.
Ma non finisce qui, perché prima di concedere la pace eterna alle vinacce ormai esauste, arrivava il momento del colpo finale, quello che Franz chiamava quartarolo, conosciuto altrove come quartanello o, più recentemente nelle nostre campagne, come puntalone (al puntalòun). Qui le vinacce venivano passate in un tinello e sottoposte alla pressione di una pressa idraulica, oppure pressate con un bastone (un puntale, appunto) che andava dal soffitto della cantina alle assi che schiacciavano quelle povere vinacce ormai esauste, per estrarne ogni possibile traccia di vita. Inutile dire che, secondo Franz, anche in questo caso un po’ di Trebbiano poteva cambiare tutto e rendere persino il puntalone un vino accettabile. “Tiene tant’acqua”, d’altronde, si diceva.
Il Metodo Aggazzotti per fare il Lambrusco
Scrive Francesco: “Anche coi lambruschi, se non si premette la concentrazione e saccarizzazione, non si ottiene un vino di merito distinto. Facendoli fermentare senza graspe e bucce, i vini guadagnano in limpidezza, asciuttezza e leggerezza, ma perdono in sapore e rivelano troppo la loro povertà d’alcol, e perciò non trovano favore né presso di noi né altrove”. Questo concetto viene ribadito più volte in letteratura, ovvero la necessità di appassire le uve al sole per alcuni giorni e di lasciare graspe e bucce nel mosto per ottenere un vino di maggior corpo. È inoltre raccomandato che la prima torchiatura (quella che avviene contemporaneamente al mezzo vino di cui sopra) venga riposta nel tino assieme al mosto, cosa che, tra l’altro, è ancora oggi normale prassi in molte cantine di tutta Italia. Almeno in quelle dove si fa ancora il vino con l’uva 🍇. Questo vale in particolar modo per le torchiature delle uve coltivate in collina, dove, come detto sopra, secondo lui i vini erano molto colorati e tannici, per cui talvolta metà di questo estratto veniva usato come rinforzo per lambruschi altrimenti troppo “scarichi”.
Viene però fatta notare una cosa importante, ovvero che per il suo personale metodo di produzione del Lambrusco di Sorbara, questo non è necessario. Infatti, in un’altra vecchia rivista dell’Ottocento, riporta un metodo che permette di seguire il suo sistema dalla vigna al bicchiere.
Saltiamo la parte della vigna, eccetto per un importante dettaglio. Nonostante Aggazzotti avesse una vigna personale a Formigine, secondo lui il terreno più adatto per il Lambrusco rimaneva nella zona di Sorbara e Bomporto, a causa di una lunga serie di osservazioni. In particolare, queste viti dovevano necessariamente essere maritate all’albero, in modo da creare tralci di 8-10 metri. Questo sistema di coltivazione, ormai in disuso, era, secondo il cavaliere, l’unico in grado di garantire la materia prima necessaria alla produzione successiva. Questo, a mio avviso, chiarisce un punto: si tratta di un mosto leggero e acido, che schiariva ulteriormente a causa del suo sistema di coltivazione. È ovvio, quindi, che facesse riferimento a una tipologia di mosto diversa da quella che conosciamo oggi. Numerosi studi del secolo scorso sui mosti di viti allevate a tutore vivo o a vigna mostrano che le differenze erano sia numeriche che visibili. A riprova di ciò, il Lambrusco di Sorbara viene descritto dal nostro come un vino che mediamente raggiunge gli 8 gradi (oggi non potrebbe neppure essere normativamente considerato vino), da bere tra i 2 e i 6 anni di invecchiamento8. Forse possiamo collegare questo importante dettaglio, ovvero la delicatezza di questo mosto, con l’idea del cavaliere di produrre il Lambrusco senza esportazione di solidi o liquidi e senza rompere il cappello, riducendo però i tempi di macerazione. Chiariamo: si lasciava il vino le graspe e tutto il resto nel tino, senza toccarlo, senza follatura.
Una nota sull’altezza della vigna per tornare alla vite maritata. Immaginate le campagne di Sorbara: zone umide e soffocanti, paludi bonificate secoli prima dai monaci benedettini.
Il consiglio di Francesco di coprire i grappoli con le foglie per proteggerli dal sole riflette una saggezza antica, adattata alle condizioni del tempo. Anche oggi, i coltivatori devono affrontare problemi come la peronospora, una delle principali malattie fungine della vite, favorita da climi umidi. Tuttavia, l’allevamento dei grappoli a 4-5 metri di altezza, tipico delle vigne maritate agli alberi, permette di mantenere le foglie attorno ai frutti, offrendo una barriera naturale contro la luce diretta e favorendo una maggiore ventilazione, che riduce drasticamente la comparsa di muffe e altri problemi che colpiscono le viti allevate vicino al terreno.
Questo approccio, che potrebbe sembrare controintuitivo oggi, ha una logica radicata nella conoscenza del territorio e nelle dinamiche dell’ecosistema agricolo di quel tempo, offrendo spunti di riflessione anche per le pratiche moderne.
- P. Selletti – Nuovo trattato teorico-practico di viticoltura e vinificazione, 1877 ↩︎
- Le denominazioni attuali di fatto impediscono di usare il trebbiano nel taglio, nonostante questa pratica abbia contraddistinto questo vino per secoli ↩︎
- O. Ottavi – Il vino da pasto e da commercio, 1874 ↩︎
- E. Ramazzini – articolo “I Lambruschi”, 1885 ↩︎
- Archivio di Stato di Modena ↩︎
- F. Aggazzotti – Catalogo descrittivo di tutte le varietà…, 1867 ↩︎
- E. Ramazzini – I Lambruschi Sorbara e Salamino, 1885 ↩︎
- F. Aggazzotti – Catalogo descrittivo di tutte le varietà…, 1867 ↩︎

